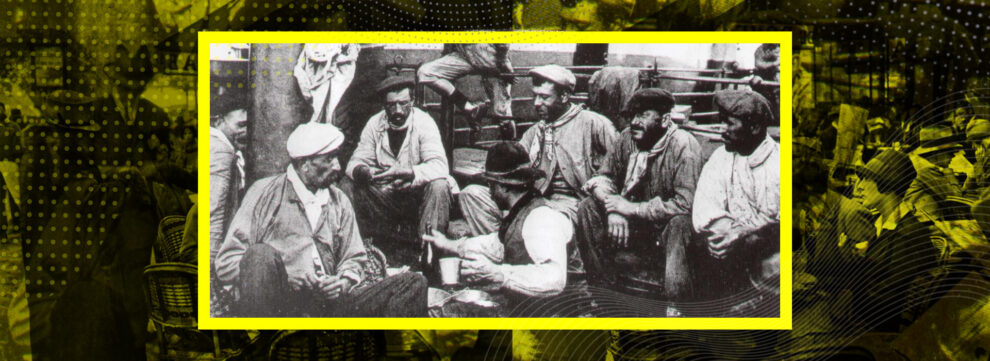
Il lato oscuro della «Belle Époque»
Esiste una «preistoria» della politica della paura e della violenza nell’Europa pre-bellica, quando il disprezzo e il terrore delle classi proprietarie verso il nascente movimento operaio influenzarono il pensiero politico e le scienze sociali
Nel numero 6 di Jacobin Italia ci siamo occupati delle molte facce della paura, dei suoi miti, dei suoi usi politici. Cosa significa fare una storia sociale e politica della paura – e della violenza? Ne abbiamo parlato con Matteo Millan, docente all’Università di Padova, studioso della storia della violenza politica organizzata tra Belle Époque e fascismo.
Secondo l’immagine classica, gli anni Venti europei si caratterizzano per gli echi della violenza della Prima guerra mondiale, che lascia in eredità una «brutalizzazione» della politica – secondo una celebre espressione dello storico George Mosse – che si mostra drammaticamente, certo in modi diversi, in Italia e in Germania. Il tuo progetto di ricerca in corso, intitolato The Dark Side of the Belle Époque. Political Violence and Armed Associations in Europe before the First World War, prende le mosse dall’idea che le radici della violenza politica novecentesca vadano cercate prima della guerra mondiale, nel periodo della Belle Époque appunto; e non solo nel campo della politica, nella contrapposizione tra sovversivi e conservatori, ma nelle relazioni sociali.
Almeno in parte, è proprio così. A partire dalla definizione di George Mosse di brutalizzazione, si è sviluppata negli ultimi anni una solida e convincente storiografia che ha sottolineato come le origini della violenza postbellica siano da ricercare non tanto nell’esperienza della trincea in sé, quanto piuttosto nelle dinamiche specifiche del dopoguerra. Focalizzandosi soprattutto sull’Europa centro-orientale, questa storiografia ha sottolineato il ruolo assolutamente cruciale della sconfitta nel disgregare gli apparati statali e le forme di legittimità tradizionali. In questa sorta di vuoto di potere emerge un nuovo modo di fare politica, in cui la violenza organizzata di gruppi paramilitari e milizie gioca un ruolo assolutamente fondamentale. È quanto accade, per esempio, durante la guerra civile russa, nel Baltico o nella stessa neonata repubblica tedesca. Il mio progetto di ricerca prende le mosse tanto dalla teoria della «brutalizzazione» quanto da questa storiografia più recente, con l’obiettivo di capire se esista una sorta di «preistoria» della violenza organizzata anche in quel tempo e in quel contesto politico che è l’Europa pre-bellica. Un’Europa che solo retrospettivamente sarebbe stata chiamata della Belle Époque. L’obiettivo del progetto non è tanto, tuttavia, quello di stabilire paragoni o parallelismi improponibili. In termini numerici ma soprattutto di reale violenza dispiegata, i gruppi che io e il mio gruppo di ricerca studiamo non sono infatti assolutamente paragonabili con quelli che emergono nel contesto ben più violento del primo dopoguerra. Piuttosto, ci proponiamo di riflettere sui rapporti tra democrazia e violenza organizzata legale. Tutti i gruppi che studiamo emergono all’interno del quadro legale degli Stati liberali dell’epoca: una prima sostanziale differenza rispetto alle milizie postbelliche che si sviluppano illegalmente proprio perché in molti casi uno Stato non c’è. Ma moltissime delle associazioni armate che studiamo emergono come risposta a un aumento dei processi di democratizzazione. Per esempio, molte milizie civiche austriache (i cosiddetti Bürgercorps) nascono come una risposta delle cosiddette «classi leali» nei confronti dell’allargamento della partecipazione politica e dell’introduzione del suffragio universale nel 1907. Ma sono moltissimi i gruppi patriottici, dai battaglioni scolastici ai Volontari ciclisti e automobilisti italiani, che nascono come tentativo di ricompattare una società che si percepiva come sul punto di disgregarsi. Nell’Europa della Belle Époque, migliaia e migliaia di cittadini (maschi) vedono nell’organizzarsi armi in pugno una risposta efficace ai profondi cambiamenti sociali e politici che stavano vivendo.
Alcuni dei luoghi di confronto più feroce, già prima della guerra, erano anche zone contraddistinte da un avanzato livello di sviluppo capitalistico: per quanto riguarda l’Italia, basti pensare a Torino o alle campagne bolognesi e padane. Le classi dirigenti di questo sviluppo, industriali e agrari, provavano orrore e terrore verso la crescita del movimento dei lavoratori, delle loro rivendicazioni – e ancor di più, in alcuni casi, del loro potere, come appunto nel bolognese dove i socialisti arrivarono a controllare molte amministrazioni. Come reagirono le classi proprietarie, quali strumenti attivarono? O si potrebbe anche dire, più ampiamente: che rapporto veniva a intrecciarsi tra violenza e sviluppo economico?
Nel caso italiano, si assiste, a mio avviso, a un duplice fenomeno: un cambiamento nell’approccio politico e repressivo ai conflitti sociali da parte dello Stato, e l’emergere di forme di reazione armata privata da parte degli imprenditori. Sono due fenomeni strettamente connessi. Dopo i fatti di Milano del 1898 e le famigerate cannonate del generale Fiorenzo Bava-Beccaris, una parte delle classi dirigenti si rende conto che reprimere la protesta sociale con un bagno di sangue è controproducente in una società che sta progressivamente diventando di massa e adotta nuove soluzioni. Non è, d’altra parte, un fenomeno solo italiano: dinamiche simili si mettono in atto, per esempio, anche in Spagna dopo la Settimana Tragica (1909) e la condanna a morte di Francisco Ferrer o in Francia dopo il cosiddetto eccidio di Fourmies (1891). Nel primo caso, la mobilitazione di classi di riservisti per combattere un’insurrezione nel Marocco spagnolo dà il via a una imponente protesta popolare in tutta la Catalogna, ma soprattutto a Barcellona, dove vengono incendiate chiese e conventi e occupati i palazzi del governo. Solo dopo una settimana, le forze di polizia, l’esercito e la milizia del Somatén riescono a riprendere il controllo della città: la repressione che ne segue è brutale, con centinaia di arresti ed esecuzioni, tra cui quella del leader anarchico e pedagogista Francisco Ferrer, assolutamente estraneo ai fatti ma un perfetto capro espiatorio. A Fourmies, invece, nel dipartimento del Nord, un corteo pacifico di operai che scioperano per le otto ore viene represso nel sangue dall’esercito, lasciando sul terreno dieci morti (di cui due bambini) e 35 feriti. In entrambi i casi, la repressione brutale e per certi versi gratuita da parte delle forze dell’ordine ha conseguenze politiche molto pesanti, e anziché risolvere il problema non fa altro che esacerbarlo. Dopo i fatti di Milano, anche in Italia, è chiaro che le cannonate non possono essere la soluzione ai conflitti sociali. La risposta, soprattutto ad opera di Giovanni Giolitti, è ambiziosa e contraddittoria: davanti all’aumento significativo della conflittualità sociale, lo Stato deve garantire la propria neutralità nei conflitti sociali: la contrattazione economica diventa una questione tra le parti in causa, e le forze di polizia non avrebbero dovuto prendere le difese di una parte piuttosto che dell’altra, garantendo nel contempo il rispetto della legge. È un progetto ambizioso, che mal si concilia tanto con la disponibilità delle forze dell’ordine quanto con l’asprezza della lotta sociale, soprattutto nelle campagne emiliane. Qui, non solo le leghe socialiste riescono nel «miracolo» di stabilire – anche attraverso intimidazione e forme di violenza – un monopolio sulla manodopera, inquadrando decine di migliaia di braccianti, ma il partito socialista riesce a controllare decine di consigli comunali. La risposta degli agrari è articolata. Non sentendosi più protetti dallo Stato (nel senso, di poter godere sulla repressione preventiva delle forze dell’ordine al minimo accenno di sciopero o mobilitazione bracciantile), in molti iniziano a pensare che è necessario far da sé. Alcune compagnie, come la Società per la bonifica dei terreni ferraresi, creano corpi di polizia private per tenere i propagandisti socialisti fuori dalle proprie tenute. Altri, come gli agrari di Parma, organizzano milizie di protezione, i cosiddetti Volontari lavoratori, per tutelare i braccianti non sindacalizzati e bypassare in questo modo il controllo della manodopera esercitato dalle leghe socialiste. In molti casi, l’obiettivo non è soppiantare le leghe socialiste o le stesse forze di polizia, quanto provocare incidenti e scontri che possano poi giustificare la repressione statale. Un punto interessante da notare, tuttavia, è che non siamo davanti a proprietari terrieri assenteisti o a fittavoli incolti e brutali. L’agraria della Valle del Po è formata da avvocati, ingegneri, agronomi che fanno di quelle terre tra le più produttive al mondo e nel contempo sono abilissimi sul piano della propaganda e della propria auto-legittimazione. Lino Carrara, l’inventore dei «Volontari lavoratori» diventerà anche direttore de Il resto del Carlino. In questo caso, la creazione di corpi armati privati è il risultato di un consistente sviluppo capitalistico ed è funzionale al mantenimento di alti livelli di produttività, anche attraverso lo sfruttamento della forza lavoro. Le leghe dei lavoratori rappresentano non solo un modello politico alternativo che rischiava, nella percezione degli agrari, di minare le tradizionali gerarchie sociali, ma anche una sfida alle prerogative manageriali degli agrari e all’assoluta intangibilità della proprietà privata.
Si può dire anche, d’altra parte, che la paura del movimento operaio – e anche della violenza politica, come nel caso degli attentati degli anarchici a uomini di Stato e teste coronate – abbia stimolato non solo risposte repressive, ma anche riforme dall’alto?
Certamente. È quanto si propone di fare soprattutto Giovanni Giolitti, tanto nel campo della gestione dei conflitti del lavoro quanto nella concessione di alcune riforme sociali e previdenziali, come le assicurazioni sugli infortuni e sulla vita. È necessario notare, tuttavia, che queste politiche avvengono con fini essenzialmente conservatori. Insomma, per evitare la rivoluzione (e per molti, un assaggio si era avuto in occasione dei fatti di Milano del 1898), le cannonate non solo erano inutili ma anche controproducenti. Se lo Stato liberale (e le sue élite) volevano sopravvivere, dovevano rinnovarsi e soprattutto allargare la base sociale delle istituzioni. Quanto avviene nella pianura padana, e che ho sommariamente descritto poco fa, dimostra in realtà l’effetto boomerang delle politiche giolittiane: non solo esse non riescono a inserire le masse nelle istituzioni liberali ma anzi provocano una reazione da destra contro quelle stesse istituzioni. È importante sottolineare il fine eversivo della mobilitazione agraria. Come dirà Lino Carrara, i suoi Volontari lavoratori, rappresentavano «la forza pubblica dello Stato privato».
Come potremmo sintetizzare gli effetti di queste azioni repressive sul movimento operaio stesso, a livello politico e organizzativo, ma anche di sua capacità di difendersi e disponibilità alla violenza?
Gli effetti sono solitamente pesanti, nel senso che gli agrari sono molto spesso capaci di suscitare la reazione statale, che comporta non solo la repressione violenta ma anche lo scioglimento di leghe e circoli socialisti e l’arresto dei loro leader. In qualche modo, con la loro azione di reazione e provocazione, le associazioni agrarie tendono a smascherare i limiti della politica giolittiana della neutralità. Davanti alle provocazioni, solitamente, la risposta delle leghe è duplice. Da un lato, rafforzano la coesione interna, anche con metodi intimidatori e violenti. Chi non obbedisce alla disciplina interna viene boicottato, vale a dire, in sostanza, escluso dalla vita sociale della comunità: non solo si viene additati come crumiri, ma non si possono, per esempio, comprare i generi alimentari alle cooperative di consumo od ottenere i servizi di altri membri della comunità, dalle balie ai barbieri. Dall’altro lato, le leghe adottano una strategia di disciplina verso l’esterno, col fine di evitare a tutti i costi di accettare le provocazioni di parte padronale: il risultato – l’intervento repressivo delle forze dell’ordine – sarebbe infatti stato scontato. A volte, tuttavia, questa duplice strategia non funziona. È quanto accade, per esempio, a Guarda di Molinella (Bologna) nell’ottobre 1914, quando centinaia di lavoratori sindacalizzati attaccano un convoglio di automobili che trasporta alcuni crumiri. Sul terreno cadono cinque crumiri, uccisi a colpi di pietra e di bastone dai lavoratori organizzati. Le vittime sono quasi tutte braccianti della provincia di Padova che avevano accettato il lavoro per le disperate condizioni economiche delle loro famiglie. La repressione statale è durissima: tutte le leghe della zona vengono sciolte e vengono ordinati decine di arresti.
Non di rado, il disprezzo e il terrore delle classi proprietarie verso il movimento operaio si riflettevano nel pensiero politico e nelle scienze sociali, che parlavano di irrazionalità delle masse, rottura del principio di unità dello Stato e via dicendo. Quanto profonda è la traccia che questo giudizio ha lasciato nelle scienze sociali del Novecento?
È una traccia molto profonda. Basti pensare a grandi classici come La psicologia delle masse di Gustave Le Bon, o alla Folla delinquente di Scipio Sighele. Si tratta di un filone di studi molto ben battuto e analizzato, tanto dagli storici quanto da sociologi, filosofi o giuristi. Quello che, a mio parere, è interessante notare, è che non esiste solo questo piano «alto» e in parte codificato. C’è anche tutta una letteratura grigia fatta di pamphlet e libelli, redatta da agrari locali o da funzionari di polizia, da giornalisti e da avvocati, che riflette posizioni simili. L’idea che le folle, a maggior ragione politicizzate, siano organismi irrazionali e brutali è parte integrante del discorso pubblico: è evidente il fine di delegittimazione verso quelle forze politiche che si proponevano di organizzare tali masse. In riferimento all’eccidio di Guarda, di cui ho parlato poco sopra, in parlamento si parla di «atti e violenze ed eccidi che hanno squisito sapor barbaresco», di «folle assetate di sangue» ed «ebbre di odio». In questo quadro, lo sciopero non è visto da una parte considerevole dell’opinione pubblica come uno strumento per ottenere incrementi salariali o migliori condizioni di lavoro, ma come una minaccia all’ordine sociale. Nelle loro lettere, per esempio, al governo o al prefetto, gli agrari bolognesi rivendicano come un aumento di pochi centesimi nella paga oraria dei braccianti non fosse altro che il primo passo verso la collettivizzazione delle terre. Ne consegue che, nella percezione di molti agrari, cedere su pochi centesimi una volta, avrebbe potuto far crollare la diga dell’ordine sociale e portare alla rivoluzione. Le stesse amministrazioni comunali controllate dai socialisti vengono percepite come meccanismi per espropriare la proprietà, poiché solitamente esse finanziavano asili, cooperative di consumo o sussidi di disoccupazione attraverso un aumento delle tasse sulla proprietà. Insomma, è evidente che l’antisocialismo assumeva in moltissimi casi le sembianze di una critica alla stessa democrazia liberale e ai suoi strumenti, dal voto alla contrattazione sociale.
Uno dei punti di vista attraverso cui possiamo guardare a queste vicende è quella della cosiddetta «storia delle emozioni»: in prima istanza la paura, quella da parte delle classi proprietarie, e quella che volevano incutere ai lavoratori. Ma anche la speranza, la rabbia, e via dicendo. Cosa ci può dire la storia delle emozioni riguardo alla storia sociale o, meglio, dei rapporti tra classi sociali? Attraverso quali strumenti e documenti possiamo studiarla?
La storia delle emozioni è un filone storiografico e un approccio metodologico che negli ultimi anni sta godendo di grande fortuna. Ma è anche stato oggetto di molte critiche. Sicuramente, dal mio punto di vista, è uno strumento che può rivelarsi utile per enucleare e comprendere la profondità – anche emozionale – degli scontri e delle violenze in atto in contesti attraversati da aspri conflitti sociali. Ma ci sono sicuramente vari problemi. Da un lato, non esiste una metodologia univoca, e c’è sempre il rischio di aggiungere poco di nuovo a quanto si sa già. Dall’altro lato, molte delle fonti che gli storici solitamente usano o semplicemente hanno a disposizione per raccontare conflitti sociali, scioperi, manifestazione di violenza sono diverse da quelle usate da chi fa storia delle emozioni (diari, lettere, memorie). Tuttavia, penso che senza comprendere l’odio profondo nei confronti della figura del crumiro o, al contrario, il disprezzo per la figura del bracciante, non si possa capire fino in fondo quel surplus di violenza – violenza eccessiva, non funzionale a uno scopo, per certi versa gratuita – che caratterizza molti degli scontri, per esempio, nel contesto della valle del Po. Le emozioni sono socialmente (e quindi storicamente) costruite e hanno una lunga durata, che va al di là dell’atto singolo che origina la paura o l’odio o l’umiliazione. È chiaramente pretestuoso, ma parlare di violenze dal «sapore barbaresco» in riferimento ai fatti di Guarda fa emergere il radicamento di cliché, pregiudizi, modi di pensare radicati. Gli storici devono tener conto di questi ingredienti che compongono le emozioni (che sono meno effimere di quanto si potrebbe pensare) e al tempo stesso della loro lunga durata per andare al di là di cronologie consolidate e comprendere, per esempio, le connessioni tra periodo pre-bellico e la campagna di terrore messa in atto dalle squadre fasciste in quegli stessi territori a partire dal 1920.
Negli ultimi anni si è parlato con insistenza, ma spesso anche con genericità, di incombente minaccia di ritorno del fascismo a proposito di un discorso pubblico sempre più aggressivo e della crescita di vere e proprie azioni violente. D’altra parte, che i critici di questa idea hanno voluta smontarla con argomentazioni forse un po’ troppo accademiche, rilevando che nella violenza diffusa di oggi non si presentano i caratteri «da manuale» dello squadrismo (tra cui, va da sé, gli echi della guerra o la paura del bolscevismo). La prospettiva che abbiamo seguito sin qua potrebbe portarci, però, a dare di questo interrogativo una lettura un po’ diversa – e un po’ meno astorica. Per esempio, notando che non di rado i ceti dirigenti economici hanno ostentato di avere più paura di possibili riforme a sinistra che non delle derive a destra (penso, da ultimo, all’atteggiamento di testate come l’Economist nei confronti del Labour di Corbyn).
Oggi sicuramente il concetto di fascismo è tornato particolarmente presente nel discorso pubblico. Questo pone, inevitabilmente, al centro della questione un rapporto tra storia e attualità particolarmente stringente e pone un problema particolarmente complesso. Esiste sicuramente un «fascismo storico», quello dei regimi dell’Europa tra le due guerre. Per esempio, lo squadrismo italiano è un fenomeno specifico e cronologicamente ristretto: nasce in un contesto storico in gran parte irripetibile ed è di gran lunga più violento tanto delle milizie pre-belliche quanto dei gruppi di estrema destra del giorno d’oggi. È anche vero, io penso, che la categoria di fascismo rappresenta quella che più immediatamente abbiamo a disposizione per descrivere il fenomeno di radicalizzazione della politica a cui assistiamo. E sicuramente i processi di umiliazione e la denigrazione del diverso (dall’ebreo al migrante all’omosessuale) hanno molto a che vedere con quanto messo in atto dai movimenti fascisti storici. Parlo non a caso di umiliazione e denigrazione, perché credo siano sentimenti potenti e capaci di mobilitare reazioni anche violente – ancora, forse, la storia delle emozioni ci può venire in aiuto. E in questo ambito, ma ce ne sono molti altri, le somiglianze con quanto avveniva un secolo fa sono stringenti. Al tempo stesso, nel descrivere la crisi attuale come un ritorno del fascismo, vedo anche il rischio di non coglierne appieno le peculiarità e i caratteri distintivi. Vale a dire, per esempio, la centralità dei social media o la violenza a bassa intensità di molti episodi. Insomma, il rischio, a mio avviso, è lasciarci sfuggire cosa c’è di nuovo e potenzialmente pericoloso per la democrazia nella radicalizzazione della politica di oggi. Se usato con questa avvertenza, a mio avviso, la categoria di fascismo è uno strumento interpretativo utile per l’analisi della politica, in attesa magari di mettere a punto qualcosa di più specifico. Resta il fatto che stiamo vivendo, credo, un momento di crisi della democrazia, in cui il fascino per l’uomo forte e per un sostanziale sacrificio delle libertà e dei diritti a favore della sicurezza e dell’ordine sono molto forti e probabilmente richiedono la messa in campo di soluzioni innovative e articolate.
*Matteo Millan è professore associato all’Università di Padova, dove coordina il progetto di ricerca ERC ‘The Dark Side of the Belle Époque. Political Violence and Armed Associations in Europe before the First World War’. È autore di Guerra di servizi (2009) e Squadrismo e squadristi nella dittatura fascista (2014). Bruno Settis è autore di Fordismi. Storia politica della produzione di massa (il Mulino 2016) e ricercatore alla Fondazione Einaudi di Torino.
La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua.







